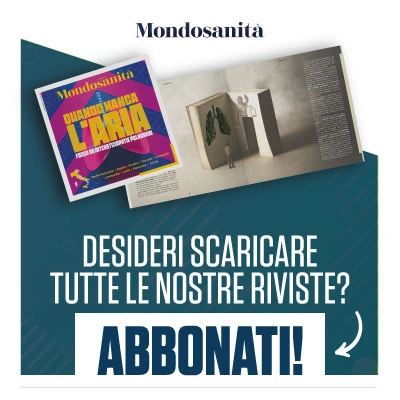La mielofibrosi è una rara affezione del sangue che colpisce essenzialmente il midollo osseo, la sede principale della produzione delle cellule che popolano il torrente circolatorio. La proliferazione provoca la formazione di tessuto fibroso nel midollo, impedendo la corretta espansione del tessuto emolinfopoietico, e portando a una differenziazione anomala delle cellule del sangue. Si stima che circa 350 italiani ricevano ogni anno una diagnosi di mielofibrosi, con un’incidenza maggiore tra i 60 e 70 anni, ma non esclusivamente: il 15% dei casi si verifica in persone sotto i 55 anni.
Manifestazioni e sintomi
La mielofibrosi può essere inizialmente asintomatica, ma nella maggior parte dei casi viene diagnosticata in fasi avanzate. I sintomi principali includono:
1. Anemia: presente in circa il 40% dei pazienti al momento della diagnosi.
2. Splenomegalia: ingrossamento della milza che causa disagio e limita le attività quotidiane.
3. Trombosi ed Emorragie: complicanze che possono risultare fatali.
4. Stanchezza: una grande debolezza che compromette la qualità della vita.
5. Perdita di peso e sudorazioni notturne.
Trattamento – la condotta terapeutica in presenza di mielofibrosi dipende dalla severità dei sintomi e dalle caratteristiche individuali del paziente, inclusi età e comorbidità. Tra le opzioni terapeutiche disponibili:
i. Trapianto di Cellule Staminali Allogenico: l’unica cura potenzialmente definitiva, riservata a pazienti con prognosi sfavorevole e in buono stato generale.
ii. Inibitori della Chinasi Janus (JAK): farmaci come ruxolitinib, fedratinib e il recente momelotinib, che riducono i sintomi e migliorano l’anemia.
La novità
L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha recentemente approvato l’uso di momelotinib, un nuovo inibitore della chinasi Janus (JAK), inibitore selettivo delle proteine Jak1 e Jak2 e del recettore dell’activina A di tipo 1 (Acvr1) per il trattamento della splenomegalia e dei sintomi correlati in pazienti adulti con anemia moderata o severa affetti da mielofibrosi. Questo farmaco di GSK ha dimostrato di ridurre i sintomi e la necessità di trasfusioni. «È bene avere a disposizione nuovi farmaci come questo, che possano contrastare una condizione di sofferenza» sottolinea Antonella Barone, presidente dell’Associazione Italiana Pazienti con Malattie Mieloproliferative (AIPAMM).
Anche a fronte dei progressi in medicina, restano aperte due grandi questioni: prevenire l’evoluzione della mielofibrosi in leucemia mieloide acuta e gestire l’eccessivo ingrossamento della milza. La terapia richiede un approccio personalizzato, con una combinazione di farmaci e supporto mirati a migliorare la qualità della vita dei pazienti.
«L’unica cura definitiva nella mielofibrosi, al momento, è il trapianto di cellule staminali allogenico (da donatore sano), riservato alle forme con caratteristiche prognostiche sfavorevoli, a chi è in buono stato generale e ha meno di 70-75 anni, la selezione è legata alla complessità del caso clinico e ai rischi che l’intervento comporta» spiega Francesco Passamonti, direttore dell’Ematologia alla Fondazione IRCCS Policlinico di Milano. «Le altre terapie oggi disponibili – afferma lo specialista – consentono di allungare la sopravvivenza e ridurre i sintomi debilitanti permettendo, nella maggior parte dei casi, il ritorno alle attività quotidiane e lavorative e a una normale vita sociale». «L’efficacia del Jak inibitore momelotinib è stata analizzata in tre importanti studi. Il primo, Simplify 1, ha preso in considerazione pazienti naïve ai Jak inibitori e randomizzava momelotinib versus ruxolitinib, dimostrando che momelotinib è più efficace nel migliorare i livelli di emoglobina.
Lo studio Simplify 2, invece, con pazienti che avevano già ricevuto Jak inibitori e randomizzava momelotinib con il miglior trattamento disponibile a quei tempi, ha dimostrato l’efficacia di momelotinib nel controllo della splenomegalia e dei sintomi, oltre a un miglioramento dell’emoglobina». «Il terzo studio è Momentum – conclude il professor Passamonti – nel quale pazienti che avevano ricevuto ruxolitinib ed erano anemici, si randomizzavano a ricevere momelotinib versus danazolo, una terapia ormonale androgenica che utilizziamo oggi per il controllo dell’emoglobina. Questo studio ci ha consentito di ottenere un tasso di indipendenza a 24 settimane del 30% rispetto a meno del 20% con la terapia standard. Possiamo dire che l’efficacia nei riguardi della milza, dei sintomi e dell’emoglobina è stata documentata». Dal punto di vista della tollerabilità, «si vede che il farmaco è molto ben tollerato – conclude Passamonti – Non ci sono eventi avversi da segnalare. È molto importante, come con gli altri Jak inibitori, prestare attenzione al rischio infettivo, perché l’inibizione Jak porta a una riduzione di alcuni sottotipi di linfociti T, che può predisporre a certe infezioni. È quindi fondamentale vaccinare i pazienti e fornire informazioni sul rischio effettivo, in modo che la gestione sia la più sicura possibile».
La mielofibrosi rappresenta una sfida complessa, ma i progressi nel campo della ricerca e delle terapie cambiano la prospettiva nel suo insieme. La gestione della malattia richiede un approccio multidisciplinare e una continua innovazione nel campo terapeutico.
«In concreto: la terapia dipende dai sintomi e, per stabilire come procedere, servono una biopsia osteomidollare (utile ripeterla in caso di sospetta progressione) e lo studio dei geni coinvolti (quali JAK2, CALR o MPL) con test molecolari molto sensibili e standardizzati» chiarisce Alessandro Maria Vannucchi, ordinario di Ematologia all’Università di Firenze e direttore dell’Ematologia all’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi. «Nei pazienti più giovani si utilizza un test più complesso, effettuato in laboratori specializzati, denominato NGS (next generation sequencing) che permette di ricercare mutazioni aggiuntive le quali, se presenti, forniscono informazioni importanti sulla prognosi della malattia, aiutando nella scelta della procedura trapiantologica».
La mielofibrosi può peggiorare più o meno lentamente nell’arco di diversi anni, con modalità variabili a seconda del paziente. In genere la fase iniziale consiste in un danno alla struttura del midollo osseo. è la fase precoce. Nella fase avanzata compare la fibrosi midollare e si evidenzia una fuoriuscita di cellule staminali immature dal midollo osseo. Queste, attraverso il sangue, raggiungono la milza e il fegato, dove si depositano.
Considerando le molteplici difficoltà affrontate dai pazienti con mielofibrosi, l’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma) ha creato un gruppo dedicato a queste persone. L’obiettivo principale è far emergere le loro necessità, facilitare occasioni di incontro e dialogo, e fornire informazioni affidabili. Tra le varie iniziative, è stato lanciato un forum online dove pazienti e familiari possono condividere le proprie esperienze e interagire.