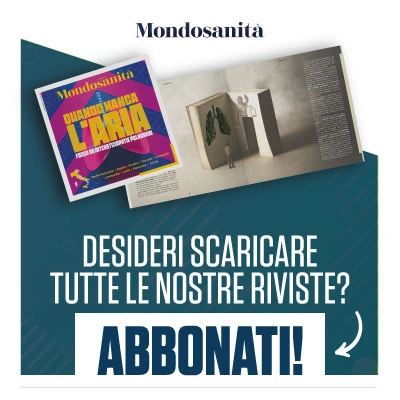La ricerca SAVE-O2 mostra che livelli moderati di ossigeno possono essere sicuri ed efficaci
Un’indagine su vasta scala, condotta dalla University of Colorado School of Medicine e pubblicata su JAMA Network Open, suggerisce che mantenere i pazienti traumatizzati a un livello di saturazione di ossigeno (SpO₂) moderato – compreso tra il 90% e il 96% – può essere sufficiente a garantire buoni risultati clinici, evitando possibili effetti avversi associati a un uso eccessivo di ossigeno. Lo studio SAVE-O2 (Strategy to Avoid Excessive Oxygen) ha coinvolto circa 13.000 pazienti adulti ricoverati in otto centri traumatologici di livello 1 negli Stati Uniti, documentando un approccio alternativo alla fornitura di ossigeno tradizionale in emergenza.
Nei reparti di pronto soccorso e di terapia intensiva, i protocolli standard raccomandano spesso l’impiego di alte concentrazioni di ossigeno per i soggetti con trauma grave, al fine di garantire l’apporto adeguato ai tessuti, in particolare al cervello e ad altri organi vitali. Tuttavia, il professor Adit Ginde, MD, MPH, primo firmatario dello studio e docente di medicina d’urgenza alla University of Colorado, sottolinea che l’evidenza su un utilizzo ottimale dell’ossigeno resta incompleta. Per alcuni pazienti, la somministrazione continua di ossigeno ad alti flussi potrebbe produrre un eccesso di radicali liberi o di stress ossidativo, danneggiando i polmoni o altri sistemi.
Sulla base di questi presupposti, SAVE-O2 è stato avviato per comprendere se un approccio più cauto nell’erogazione dell’ossigeno possa ridurre i rischi di sovraossigenazione senza compromettere la stabilità o la sopravvivenza dei pazienti.
La ricerca ha esaminato pazienti con trauma cranico, ferite penetranti o contusioni multiple che richiedevano un intervento immediato, confrontando l’efficacia di una strategia di mantenimento della saturazione SpO₂ entro il 90–96% rispetto a un regime di ossigenazione che mirava a saturazioni più elevate. I parametri misurati comprendevano:
Durata di ossigenoterapia: il numero di giorni in cui il paziente necessitava di supporto con ossigeno supplementare.
Sicurezza: mortalità, complicanze polmonari, rischio di ipossia (SpO₂ < 88%) o deterioramento neurologico imprevisto.
Risultati ospedalieri: durata complessiva del ricovero, permanenza in terapia intensiva, tassi di reintubazione o ricorso a ventilazione meccanica.
Il team di Ginde ha elaborato i dati e stabilito che l’opzione normossica (SpO₂ 90–96%) non soltanto era sicura, ma anche associata a un numero minore di giornate con ossigeno supplementare, indicando un recupero respiratorio più rapido in molti soggetti.
Uno dei punti centrali nello studio è la spiegazione dei motivi per cui, oltre un certo limite, l’ossigeno addizionale non apporta benefici. L’emoglobina, principale proteina responsabile del trasporto di ossigeno nel sangue, possiede un punto di saturazione oltre il quale
l’ossigeno supplementare non aumenta in modo sostanziale l’ossigenazione tissutale. Parallelamente, un eccesso di ossigeno può generare stress ossidativo, provocando irritazione o danni a livello degli alveoli polmonari, specialmente nei pazienti traumatizzati che spesso presentano funzioni respiratorie già compromesse.
Lo studio SAVE-O2 si collega anche a ricerche precedenti che avevano evidenziato come l’eccesso di ossigeno, soprattutto in terapia intensiva, potesse contribuire a complicanze polmonari. La novità sta nell’aver valutato in modo specifico la popolazione dei traumatizzati gravi, confermando che un regime di ossigenazione più misurato non comporta peggioramenti degli esiti clinici.
L’idea alla base di SAVE-O2 trova le sue radici nelle necessità militari di gestire traumi in teatri operativi con risorse limitate. I ricercatori del CU Center for Combat Medicine and Battlefield Research (COMBAT), in collaborazione con il Department of Defense (DoD) degli Stati Uniti, hanno cercato di capire come fornire assistenza di alta qualità in ambienti dove l’ossigeno può scarseggiare e l’evacuazione medica deve avvenire velocemente. I risultati hanno condotto a revisioni delle linee guida del Joint Trauma System, allo scopo di ottimizzare l’erogazione di ossigeno mantenendo la sicurezza del paziente.
Il professor Ginde e il suo team sottolineano che tali scoperte potrebbero trasferirsi efficacemente nei reparti di emergenza civili. Nella pratica odierna, molti ospedali continuano a impostare parametri di ossigenazione alti per pazienti in condizioni critiche, ma i dati di SAVE-O2 suggeriscono che un approccio basato su target di saturazione più moderati possa garantire risultati uguali o migliori.
Oltre a reinterpretare i protocolli ospedalieri, la ricerca ha favorito l’impiego di dispositivi innovativi per regolare l’ossigeno in modo semiautomatico. Un esempio è il prototipo O2Matic, già approvato in parte del contesto europeo e in fase di valutazione presso la Food and Drug Administration (FDA) negli Stati Uniti. Questi dispositivi sono concepiti per modulare costantemente l’erogazione di ossigeno sulla base dei valori di saturazione rilevati, alleggerendo il carico per il personale sanitario e garantendo al paziente una fornitura ottimale.
I risultati dello studio SAVE-O2, pubblicati su JAMA Network Open, rappresentano un punto di svolta nella gestione del trauma grave. Dimostrano come una strategia di ossigenazione moderata possa ridurre la durata del supporto respiratorio e non aumenti rischi come l’ipossia o la mortalità. Questa conclusione potrebbe spingere a un aggiornamento delle linee guida in materia, sia nel contesto militare, dove già è in corso una revisione, sia negli ospedali civili.
Resta da verificare l’applicabilità di questi principi a diverse categorie di pazienti critici, oltre ai traumatizzati, come soggetti con insufficienza respiratoria acuta o sepsi. Tuttavia, il professor Ginde auspica che la nuova prospettiva promuova un uso più “cauto ma sicuro” dell’ossigeno, aiutando a migliorare la qualità delle cure e ad adattare le risorse sanitarie ai reali bisogni del singolo paziente.