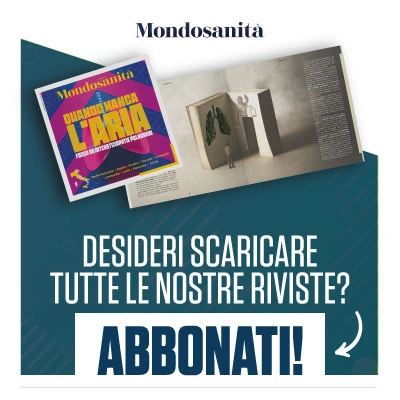Un nuovo studio esplora come le sostanze chimiche colpiscono il corpo e perché non tutti reagiamo allo stesso modo
Un gruppo di ricercatori della Duke University, in collaborazione con altri centri di ricerca, ha avviato un’indagine che utilizza minuscoli vermi trasparenti per comprendere l’impatto dei PFAS, un gruppo di sostanze chimiche artificiali estremamente persistenti nell’ambiente, spesso definite “sostanze chimiche eterne” per la loro resistenza alla degradazione. Lo studio, pubblicato sulla rivista Molecular Therapy, dimostra come i nematodi del genere Caenorhabditis elegans, piccoli vermi trasparenti spesso utilizzati nella ricerca genetica e tossicologica, possano fungere da modello efficace per identificare gli effetti di questi inquinanti sulla salute e per individuare i geni che influenzano la vulnerabilità dell’organismo ai composti tossici.
I PFAS rappresentano una vasta famiglia di sostanze chimiche utilizzate in prodotti antiaderenti, tessuti impermeabili, contenitori per alimenti e numerose altre applicazioni industriali. Questi composti tendono a disperdersi nell’ambiente e possono persistere in aria, acqua e suolo, arrivando infine a contaminare la catena alimentare. Alcuni studi indicano che i PFAS siano rilevabili persino in regioni remote, come nell’organismo di orsi polari, sollevando preoccupazioni in merito ai possibili rischi per la salute umana.
Sebbene esistano oltre 14.000 tipi di PFAS, molte di queste sostanze non sono mai state sottoposte a valutazioni tossicologiche approfondite. Analizzare ogni composto in studi su mammiferi richiede ingenti risorse e tempi prolungati. Di conseguenza, i nematodi C. elegans, larghi appena una frazione di millimetro e con un ciclo riproduttivo di pochi giorni, si prestano a test ad alta velocità e ad alta produttività, riducendo i costi e accelerando le indagini.
Il laboratorio del biologo Ryan Baugh alla Duke University ha sperimentato su decine di migliaia di C. elegans, alimentati con un brodo batterico contenente diverse concentrazioni di PFAS. La ricerca, condotta insieme alla borsista post-dottorato Tess Leuthner e alla professoressa Heather Stapleton della Nicholas School of the Environment, ha mostrato un impatto negativo sulla crescita e sulla sopravvivenza dei vermi. Tutte le 13 sostanze PFAS prese in esame hanno rallentato o bloccato lo sviluppo dei nematodi, con differenze significative nella loro pericolosità. Tra le sostanze analizzate, il PFOSA ha mostrato la maggiore tossicità, risultando fino a mille volte più dannoso rispetto al PFBA, uno dei composti meno tossici del gruppo.
I ricercatori hanno poi approfondito il ruolo delle variazioni genetiche fra diversi ceppi di C. elegans. Alcuni ceppi risultavano molto più sensibili a un PFAS specifico, mentre altri non mostravano effetti rilevanti. Questa scoperta mette in luce come le divergenze genetiche possano influenzare la risposta tossica ai contaminanti chimici e suggerisce, per analogia, che esistano differenze anche tra individui umani.
Gli autori dello studio sottolineano che molti geni di C. elegans condividono funzioni e percorsi molecolari con l’organismo umano, rendendo questo nematode un modello utile per la tossicologia ambientale. Nel corpo umano, la presenza di PFAS è stata collegata a vari effetti, tra cui alterazioni del metabolismo lipidico, possibili aumenti del rischio di alcuni tumori e problemi nello sviluppo fetale. Tuttavia, è ancora complesso stabilire con certezza i dosaggi e le esposizioni da considerare critici.
Leuthner spiega che l’obiettivo è prevedere meglio quali fasce di popolazione possano rivelarsi più vulnerabili all’esposizione a queste sostanze. Questo richiede una mappatura dei polimorfismi genetici che regolano la reazione alle molecole tossiche e, di conseguenza, una maggiore comprensione delle implicazioni cliniche in gruppi umani diversi per età, sesso o predisposizioni genetiche.
Con il sostegno dei National Institutes of Health (NIH) e del Dipartimento di Biologia dell’Università Duke, il progetto intende ora procedere alla caratterizzazione molecolare delle vie coinvolte. Inoltre, si mira a stabilire una correlazione tra i segnali di tossicità riscontrati nei vermi e gli esiti osservati in modelli animali più avanzati o in studi epidemiologici sugli esseri umani.
La diffusione dei PFAS nell’ambiente rappresenta un problema globale, poiché queste sostanze sono resistenti alla degradazione e risultano difficili da rimuovere anche con i sistemi di trattamento dell’acqua più sofisticati. Gli episodi di contaminazione delle falde acquifere e delle reti idriche potabili in diverse regioni degli Stati Uniti e di altri Paesi indicano l’urgenza di definire parametri per stabilire limiti di sicurezza e procedure di bonifica.
L’approccio delineato dallo studio della Duke University può aiutare a prioritizzare le sostanze PFAS più tossiche tra le migliaia ancora non testate e a finalizzare meglio l’impiego di risorse di sanità pubblica e ambientale. Comprendere quali varianti genetiche rendano le persone più o meno suscettibili consentirebbe anche di adottare misure di prevenzione mirate, proteggendo in particolare i gruppi ad alto rischio.
Questo lavoro indica che, attraverso nematodi di piccolissime dimensioni come C. elegans, è possibile raccogliere dati rapidi e attendibili sulla tossicità dei PFAS. La scoperta della variabilità genetica nella suscettibilità offre uno spunto per ricerche future sul potenziale impatto di queste sostanze sugli esseri umani. In un contesto dove l’inquinamento chimico assume proporzioni sempre più preoccupanti, l’innovazione nei metodi di screening risulta fondamentale per anticipare pericoli, definire linee guida e sviluppare strategie di riduzione del rischio.