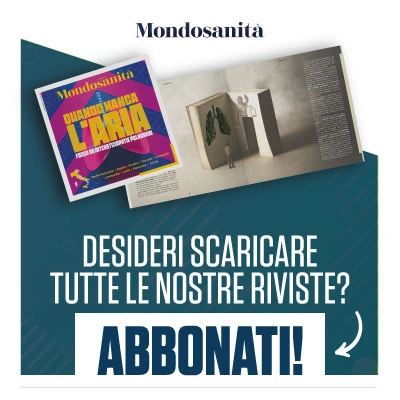Un composto naturale ricavato da alimenti comuni mostra capacità neuroprotettive in uno studio sulla sclerosi laterale amiotrofica
Un nuovo studio condotto dalla University of Missouri e pubblicato su Acta Neuropathologica Communications suggerisce che il kaempferolo, un antiossidante naturale presente in alimenti come il cavolo riccio, le bacche e l’indivia, possa svolgere un ruolo nella protezione dei motoneuroni e nel rallentamento della progressione di malattie neurodegenerative, tra cui la sclerosi laterale amiotrofica (SLA). La ricerca, guidata dalla professoressa Smita Saxena della School of Medicine, offre indicazioni su come questo flavonoide possa agire su alcune funzioni critiche delle cellule nervose, risultando potenzialmente utile anche in altre forme di demenza.
Il kaempferolo è un flavonoide – sostanza chimica di origine vegetale – che, secondo studi precedenti, possiede proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Nel contesto della SLA, la ricerca si è concentrata sulla capacità di questo composto di influenzare il funzionamento mitocondriale (strutture cellulari responsabili della produzione di energia) e di ridurre lo stress del reticolo endoplasmatico (una rete di membrane intracellulari che gestisce la sintesi e il ripiegamento delle proteine). Entrambi i processi risultano alterati nelle cellule nervose di pazienti con SLA, contribuendo alla degenerazione progressiva dei motoneuroni, ossia le cellule responsabili del controllo muscolare.
Per verificare questi effetti, i ricercatori hanno condotto test in vitro su motoneuroni derivati da pazienti affetti da SLA, osservando che l’aggiunta di kaempferolo migliorava la produzione di energia e abbassava gli indicatori di stress cellulare legati al reticolo endoplasmatico. Tali risultati, seppure preliminari, suggeriscono che il flavonoide intervenga su due fronti chiave per il benessere neuronale: da una parte facilitando la funzionalità mitocondriale, dall’altra riducendo l’accumulo di proteine mal ripiegate, ovvero proteine che, a causa di errori nella loro formazione, non assumono la struttura corretta. Questo malfunzionamento può compromettere la loro funzione e, nel tempo, contribuire al danneggiamento cellulare, come avviene in molte malattie neurodegenerative.
Nonostante le potenzialità emerse in vitro, permangono ostacoli significativi all’impiego terapeutico del kaempferolo. Innanzitutto, la molecola viene assorbita con difficoltà dall’organismo, richiedendo quantità elevate di frutta e verdura ricche del flavonoide per raggiungere concentrazioni utili. Nell’ambito di malattie neurodegenerative come la SLA, le necessità di dosaggio possono superare di molto la quantità di alimenti vegetali normalmente assunti, rendendo poco praticabile la via dell’integrazione alimentare.
Inoltre, il trasferimento del composto attraverso la barriera ematoencefalica, che protegge il cervello da agenti esterni, rappresenta una sfida ulteriore. Molti principi attivi, pur essendo assorbiti a livello sistemico, faticano a raggiungere concentrazioni efficaci nel sistema nervoso centrale. Senza un meccanismo che ne favorisca il passaggio selettivo, la quantità di kaempferolo disponibile nel tessuto neuronale potrebbe rimanere insufficiente.
Per risolvere questi problemi, il laboratorio di Saxena sta sperimentando tecnologie di nanoparticelle lipidiche capaci di incapsulare il flavonoide e di rilasciarlo direttamente nella sede d’azione. Questo approccio intende aumentare la biodisponibilità, impedendo la degradazione precoce del composto e facilitando il suo arrivo alle cellule nervose. Progetti di ricerca simili sono già in corso presso il Roy Blunt NextGen Precision Health Institute, impegnato nello sviluppo di terapie di precisione per diverse patologie, incluse quelle neurodegenerative.
La speranza è che, trasformando il kaempferolo in una forma “nano-incapsulata”, si possa incrementare la sua efficacia e ridurre potenziali effetti collaterali legati a una somministrazione sistemica intensa. Prima di passare a sperimentazioni cliniche sull’uomo, occorrerà validare la sicurezza del composto, chiarire i tempi di rilascio e verificare l’effetto prolungato sul rallentamento della neurodegenerazione.
Il meccanismo di azione del kaempferolo, che si basa sulla protezione dei mitocondri e sulla riduzione dello stress a carico del reticolo endoplasmatico, risulta rilevante anche in altre patologie che colpiscono il cervello, come l’Alzheimer e il Parkinson, in cui si riscontrano analoghi processi di accumulo di proteine mal ripiegate e disfunzione energetica. Ciò suggerisce che un eventuale trattamento a base di questo flavonoide, se perfezionato, potrebbe avere applicazioni più estese nel campo delle demenze e di altre malattie neurologiche degenerative.
Anche se i dati attuali derivano da studi in laboratorio, la validazione clinica del kaempferolo come opzione terapeutica per la SLA offre spunti interessanti per una gestione più personalizzata del deterioramento muscolare e neuronale. Accanto alle terapie standard, spesso limitate a ritardare in parte la progressione, un composto naturale con capacità antiossidanti e protettive potrebbe completare il regime farmacologico e migliorare la qualità di vita dei pazienti.
Secondo la professoressa Saxena, tali ricerche mostrano la necessità di approfondire lo studio molecolare dei principi vegetali, che talvolta mostrano un potenziale terapeutico non espresso a causa di ostacoli di assorbimento o distribuzione sistemica. Con un’opportuna ingegneria farmaceutica, queste sostanze potrebbero essere trasformate in veri e propri farmaci di supporto.
La ricerca dell’Università del Missouri, pubblicata su Acta Neuropathologica Communications, suggerisce che il kaempferolo, possa esercitare un’azione protettiva sui motoneuroni nel contesto della sclerosi laterale amiotrofica. Pur richiedendo soluzioni ai problemi di biodisponibilità, i risultati incoraggiano lo sviluppo di trattamenti complementari, basati sulla sinergia tra principi naturali e tecnologie di veicolazione farmaceutica all’avanguardia. Il prossimo passo sarà la sperimentazione preclinica con nanoparticelle o metodiche analoghe, con l’obiettivo di definire se questo composto possa effettivamente ridurre la progressione della malattia e migliorare gli esiti clinici.