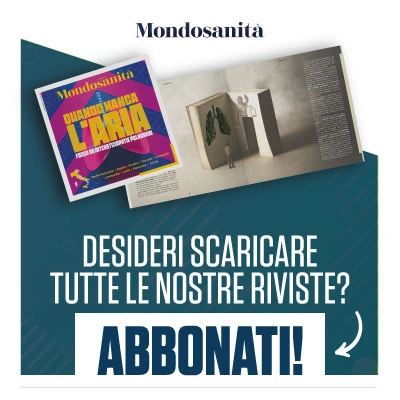Nuove evidenze suggeriscono che le microplastiche possano indebolire le placche arteriose, aumentando il rischio di ictus e infarti
Alla conferenza “Vascular Discovery 2025: From Genes to Medicine” dell’American Heart Association un gruppo di ricercatori dell’Università del New Mexico ha presentato un’osservazione che mette in relazione inquinamento da plastica e malattie cardiovascolari. Analizzando campioni di arteria carotide provenienti da interventi chirurgici, il team coordinato dal chirurgo vascolare Ross Clark ha misurato la concentrazione di micro- e nanoplastiche – frammenti inferiori a cinque micron generati dalla degradazione dei materiali polimerici – all’interno delle placche aterosclerotiche.
Il materiale studiato proveniva da quarantotto persone. Otto campioni appartenevano a donatori deceduti senza segni di aterosclerosi e costituivano il gruppo di controllo. I restanti quaranta derivavano da pazienti sottoposti a endoarteriectomia (intervento chirurgico per rimuovere le placche che ostruiscono le arterie): venti non avevano mai manifestato sintomi ischemici, mentre gli altri venti erano stati ricoverati dopo un ictus, un attacco ischemico transitorio o un’improvvisa perdita della vista. Attraverso la pirolisi seguita da gascromatografia-spettrometria di massa – una tecnica che utilizza il calore per scomporre il campione e analizza i vapori per riconoscere i diversi materiali plastici – i ricercatori hanno scoperto che la quantità di plastica cresceva con la gravità clinica. Nelle placche asintomatiche le particelle erano in media sedici volte più abbondanti che nelle arterie sane; nei pazienti con evento cerebrovascolare la concentrazione risultava cinquanta volte superiore.
Le analisi di espressione genica hanno rivelato un quadro più complesso di una semplice infiammazione acuta. I macrofagi residenti nella placca, cellule immunitarie cruciali nella stabilizzazione o nella rottura dei depositi di colesterolo, mostravano un’attività alterata: ridotta produzione di collagene, incremento di enzimi che degradano la matrice extracellulare e segnali di stress ossidativo. In altre parole la presenza di plastica sembrava interferire con i processi che mantengono la placca compatta, favorendo potenzialmente la tendenza a fissurarsi e a liberare frammenti che possono occludere un’arteria cerebrale.
Gli autori dello studio invitano alla cautela. Il lavoro è preliminare, condotto su un numero limitato di campioni provenienti da un unico centro ospedaliero. Inoltre la pirolisi potrebbe confondere minuscole particelle sintetiche con molecole lipidiche naturali: l’équipe sta perfezionando protocolli di purificazione e convalida incrociando i risultati con spettroscopia Raman, che offre maggiore specificità chimica. Resta quindi da chiarire se le nanoplastiche partecipino attivamente alla formazione della placca o se si concentrino in un tessuto già danneggiato semplicemente perché trasportate dal sangue.
Nonostante questi limiti, l’osservazione avvia una direzione di ricerca ancora poco studiata. I frammenti plastici ormai contaminano acqua potabile, aria, alimenti e sono stati rintracciati in placenta, polmoni e sangue. L’ipotesi che possano anche depositarsi nei vasi sanguigni e alterarne la biologia rappresenta un possibile tassello mancante per spiegare l’aumento del rischio cardiovascolare osservato in popolazioni fortemente esposte a inquinanti ambientali. Karen Furie, neurologa della Brown University, non coinvolta nello studio, ha commentato che l’esposizione cronica a microplastiche potrebbe diventare, in futuro, un fattore di rischio modificabile come fumo, ipertensione o ipercolesterolemia, qualora studi prospettici confermassero l’associazione.
Il team dell’Università del New Mexico, guidato dal Dr. Ross Clark intende ora seguire pazienti con stenosi carotidea nel tempo per capire se l’accumulo di plastica preceda o accompagni la progressione della malattia e se la rimozione chirurgica della placca riduca la concentrazione circolante di polimeri. In parallelo saranno sviluppati modelli cellulari e animali per indagare i meccanismi con cui le particelle interferiscono con macrofagi, cellule muscolari lisce (coinvolte nella struttura e nella contrazione dei vasi sanguigni) e cellule endoteliali, che rivestono l’interno delle arterie e regolano il flusso sanguigno e la protezione dei vasi.
Se la relazione dovesse essere confermata, la salute cardiovascolare entrerebbe a pieno titolo nel dibattito sull’inquinamento da plastica, finora incentrato soprattutto sugli ecosistemi marini e sulla tossicità respiratoria. Nel frattempo il messaggio che emerge da questo studio è prudenziale ma chiaro: la plastica dispersa nell’ambiente non è soltanto un problema di rifiuti visibili, perché i suoi frammenti invisibili possono raggiungere il nostro sistema circolatorio e, forse, comprometterne l’equilibrio.