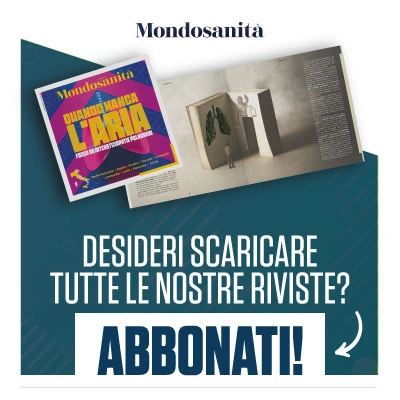Dalla sanità all’istruzione, sempre più lavoratori crollano sotto il peso dello stress cronico. Cause, effetti e strategie per invertire la rotta.
Negli ultimi anni, la sindrome del burnout ha assunto proporzioni quasi epidemiche nel mondo del lavoro occidentale tecnologicamente avanzato, riflettendo cambiamenti significativi negli ambienti e nelle modalità lavorative.
La crescente priorità data alle esigenze economiche rispetto ai valori umani pone una forte pressione sui lavoratori, chiamati ad adeguarsi a richieste sempre più incalzanti. Quando il divario tra le risorse individuali e le richieste organizzative si amplia, il costo umano diviene elevato, interessando in particolare professioni ad alto contatto emotivo come quelle sociali, sanitarie e dell’istruzione, dove le relazioni interpersonali, pur potenzialmente gratificanti, possono anche rivelarsi fonti di notevole stress, tanto più in un contesto acuito dalla pandemia di Covid-19 e dalla carenza di risorse.
Ne parliamo con Giovanni Muttillo, Direttore UOC Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Socio Sanitarie Centro Specialistico Ortopedico e Traumatologico ASST G. Pini CTO Milano e Dosolina Rapacchietta, laureata in Scienze Infermieristiche, Psicologia ad indirizzo clinico, abilitata all’esercizio della professione di Psicologo, che insieme a Domenico De Berardis, Anna Ceci e Aviano Rossi sono gli autori del libro Burnout nelle professioni sanitarie – Strategie di prevenzione e benessere organizzativo pubblicato con la Casa Editrice Ambrosiana, Distribuzione esclusiva Zanichelli.
Dottor Muttillo, se mettiamo insieme l’ambiente sanitario e lo stress lavoro-correlato, quali dati emergono?
L’analisi della letteratura scientifica internazionale rivela una vulnerabilità sistemica del personale sanitario allo stress lavoro-correlato (SLC) e al burnout. Questa problematica emerge come il secondo più frequente problema sanitario legato all’attività lavorativa in Europa, colpendo circa il 22% dei lavoratori dell’UE nel 2005 e contribuendo al 40-60% delle giornate lavorative perse a livello europeo. Sebbene il contesto lavorativo possa fungere da ambiente privilegiato per la prevenzione, la percezione dei rischi per la salute è in aumento tra i lavoratori europei, con lo stress che incide significativamente anche su patologie cardiovascolari (16% negli uomini, 22% nelle donne) e disturbi della salute mentale.
Dai dati forniti dal rapporto dell’Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (luglio 2002) emerge che:
• una persona su quattro percepisce il proprio lavoro come estremamente stressante;
• più del 28% dei lavoratori è colpito dalla sindrome del burnout;
• lo stress legato all’attività lavorativa incide su ¼ delle assenze di almeno due settimane dal luogo di lavoro sotto forma di vari problemi di salute;
• il settore più colpito è quello dei servizi sanitari;
• i gruppi più a rischio sono i lavoratori giovani, temporanei e anziani. Lo stress è visto come il primo passo di un processo che può condurre l’individuo a confrontarsi con uno stato di esaurimento emotivo.
Le conseguenze dello stress correlato al lavoro e del burnout nel personale sanitario sono gravi e multidimensionali:
salute fisica e mentale degli operatori – si osservano incrementi di disturbi psicosomatici (cefalee, problemi gastrointestinali, dolori muscolo-scheletrici), insonnia, ansia, depressione, disturbi del sonno, abuso di sostanze e, nei casi più severi, ideazione suicidaria. La continuità tra stress lavorativo e pressioni private altera inoltre le relazioni interpersonali nel contesto familiare e sociale;
qualità e sicurezza delle cure – il burnout è correlato a ridotta empatia, depersonalizzazione del paziente, diminuzione dell’attenzione, incremento degli errori diagnostici e terapeutici, e una complessiva riduzione della qualità dell’assistenza erogata;
performance lavorativa – si registra un calo della motivazione, una diminuzione della capacità di problem-solving e della creatività, unitamente a un aumento dell’assenteismo e del turnover del personale;
costi economici – lo stress e il burnout generano oneri economici significativi per i sistemi sanitari, dovuti ad assenze per malattia, perdita di produttività e la necessità di reclutamento e formazione di nuove risorse.
Questi dati evidenziano la necessità imperativa di implementare strategie preventive e di intervento mirate, sia a livello organizzativo che individuale, per mitigare gli effetti deleteri dello stress e del burnout nel contesto sanitario, a beneficio sia degli operatori che della qualità dell’assistenza.
Dottoressa Rapacchietta, quali sono le cause principali e quali gli effetti sulla salute?
Il Burnout è una sindrome multifattoriale complessa, originata dall’interazione dinamica di variabili individuali, organizzative e sociali.
A livello individuale, il rischio è influenzato dalla qualifica professionale (es. medici, infermieri, insegnanti, psicologi mostrano elevato esaurimento emotivo) e da specifici tratti di personalità, come il nevroticismo (ansia, instabilità), la personalità di Tipo A (competitività, ma difficoltà d’ascolto), il tratto alessitimico (difficoltà nell’identificare ed esprimere le emozioni) e l‘introversione (tendenza alla chiusura e percezione logorante dei conflitti).
Le variabili organizzative che contribuiscono al burnout includono disfunzioni strutturali e una discordanza tra le caratteristiche di ruolo e caratteristiche individuali. Fattori di rischio chiave sono: sovraccarico di lavoro, carenza di risorse, mancanza di controllo, percezione di ingiustizia (compenso, gratificazione, equità), eccessiva burocrazia, scarsa coesione di gruppo ed episodi di violenza sul luogo di lavoro.
Infine, le variabili sociali esterne al contesto lavorativo, quali pressioni sociali, richieste familiari, problemi comunitari e carenza di supporto sociale, possono esacerbare lo stress, aumentando la vulnerabilità e portando al burnout se l’esposizione è prolungata.
Tutte queste variabili che delineano il burnout definito come una risposta emotiva ad uno stress cronico all’interno delle organizzazioni si manifestano attraverso tre dimensioni interrelate e scientificamente riconosciute:
esaurimento emotivo – rappresenta la dimensione centrale e il punto di partenza del burnout. Si caratterizza per un profondo senso di logoramento e l’esaurimento delle risorse emotive dell’individuo, che percepisce un sovraccarico emozionale tale da non riuscire più a gestire gli aspetti critici del proprio lavoro;
depersonalizzazione – è una risposta negativa e distaccata verso i destinatari della prestazione professionale. L’operatore sviluppa un atteggiamento cinico e freddo, perdendo la capacità di stabilire una relazione d’aiuto empatica. Questa dimensione è considerata distintiva del burnout;
ridotta Realizzazione Personale – si manifesta come una sensazione di diminuita competenza e un calo nel desiderio di successo. L’individuo perde la motivazione al lavoro, sperimentando frustrazione che può culminare nel desiderio di cambiare impiego.
Gli effetti sulla salute, derivanti dal disagio lavorativo, producono una vasta gamma di reazioni avverse che si manifestano significativamente sia a livello fisico sia, e soprattutto, a livello psicologico e mentale:
reazioni Fisiologiche – alterazioni cardiovascolari (es. ipertensione, tachicardia), astenia cronica e disturbi del sonno (faticabilità, insonnia), manifestazioni dolorose (es. emicrania), problemi sessuali, disfunzioni dermatologiche e gastrointestinali, spesso inquadrabili come malattie psicosomatiche;
reazioni psicologiche – si osservano stati d’ansia, crollo dell’autostima, apatia, demotivazione e cinismo. La relazione d’aiuto si deteriora, diventando fonte di ulteriore stress.
È fondamentale distinguere il burnout dalla depressione maggiore. Quest’ultima è pervasiva e colpisce il sé globale dell’individuo, mentre il burnout è specificamente circoscritto all’ambito lavorativo, intaccando il sé professionale. Si sviluppa gradualmente, potendo rimanere a lungo non riconosciuto.
Reazioni comportamentali: questi effetti rappresentano un rischio significativo per la salute e includono: assenteismo, abuso di sostanze (alcol, nicotina), impulsività, isolamento sociale dai colleghi, perdita dell’autocontrollo, conflitti familiari, comportamenti di evitamento (es. controllo frequente dell’orologio).
Comprendere la natura multifattoriale e le diverse manifestazioni del burnout è cruciale per la sua prevenzione e per lo sviluppo di interventi mirati a tutelare la salute e il benessere dei lavoratori.
Ci sono altre professioni fortemente a rischio. Che tipo di elementi hanno in comune?
Sì, il rischio di burnout non è limitato solo alle Professioni Sanitarie. Sebbene operatori sanitari come medici, psichiatri, psicologi, infermieri e soccorritori del 118 siano statisticamente tra le categorie più colpite, numerose altre professioni presentano un elevato rischio a causa di lunghe ore lavorative, scadenze stringenti e pressioni elevate sulla produttività.
Tra le professioni particolarmente a rischio si annoverano: insegnanti – esposti a carichi emotivi e cognitivi significativi, con classi numerose e richieste crescenti; forze dell’ordine e di soccorso – includono vigili del fuoco, poliziotti, carabinieri, membri della guardia di finanza e agenti penitenziari. Queste figure affrontano quotidianamente situazioni ad alto impatto emotivo, traumi e violenza, che possono portare a un profondo esaurimento emotivo. Manager di grandi aziende: spesso sottoposti a intense pressioni per il raggiungimento di obiettivi, con responsabilità elevate e la necessità di conciliare vita privata e obblighi professionali. Autotrasportatori spesso sottoposti a orari di lavoro lunghi, e alla costante distanza da casa, che può portare a sviluppare un senso di depersonalizzazione.
Le professioni di medico, insegnante e forze dell’ordine condividono un insieme di elementi scientificamente e psicologicamente rilevanti che le espongono a un elevato rischio di burnout:
elevate richieste emotive e interpersonali (lavoro relazionale); contatto umano intenso: queste professioni implicano un’interazione diretta e prolungata con individui in stati di vulnerabilità, sofferenza o conflitto (es. medico-paziente, insegnante-studente, poliziotto-cittadino). Impegno empatico e risonanza emotiva: richiedono un significativo investimento emotivo e la capacità di entrare in risonanza con emozioni intense (dolore, paura, rabbia), un’empatia forzata che può condurre all’esaurimento emotivo, dimensione centrale del burnout. Responsabilità sull’altrui benessere: la consapevolezza dell’impatto diretto sulla vita, salute, educazione o sicurezza altrui genera una pressione psicologica intensa. Esposizione a situazioni stressanti e traumatiche: contatto con sofferenza e trauma – medici e soccorritori sono esposti a malattia grave, dolore e decesso. Poliziotti e forze dell’ordine affrontano violenza, criminalità e traumi. Gli insegnanti possono confrontarsi con bullismo e problemi familiari degli studenti. Moral Distress – la necessità di prendere decisioni difficili, talvolta in conflitto con i propri valori etici (es. risorse limitate), induce un profondo disagio interiore. Rischio personale – per forze dell’ordine e soccorritori, esiste un rischio fisico e psicologico diretto legato alla natura intrinseca del lavoro. Carico di lavoro elevato e scarsità di risorse. Burocrazia e carichi amministrativi – La crescente complessità burocratica e l’onere amministrativo sottraggono tempo all’attività principale, contribuendo a frustrazione ed esaurimento. Mancanza di autonomia: nonostante l’alta specializzazione, l’autonomia decisionale percepita è spesso limitata da direttive organizzative e protocolli stringenti, contribuendo alla depersonalizzazione e alla ridotta realizzazione personale.
In sintesi, queste “professioni di aiuto” o di “servizio pubblico” sono caratterizzate da alto impatto emotivo, elevate richieste prestazionali, risorse spesso limitate e una costante esposizione a situazioni stressanti e potenzialmente traumatiche. Tali elementi creano un terreno fertile per lo sviluppo dell’esaurimento emotivo, della depersonalizzazione e della ridotta realizzazione personale, le dimensioni cardinali del burnout.
È un problema di rilievo di cui, in realtà, si parla poco secondo voi?
Sì, è un problema di rilievo di cui, in realtà, si parla ancora troppo poco rispetto alla sua oggettiva gravità e diffusione. Il burnout: una patologia sottovalutata con ripercussioni sistemiche.
L’attuale crisi in diversi settori, in particolare quello sanitario, sta acutizzando la riduzione della realizzazione personale in molti operatori, determinando atteggiamenti negativi sia verso sé stessi che verso gli altri. In un clima di malessere organizzativo percepito, la probabilità di sviluppare stress e burnout aumenta significativamente. Di conseguenza, l’analisi e l’implementazione di interventi preventivi rappresentano un dovere ineludibile per le organizzazioni, specialmente quelle sanitarie, al fine di garantire la massima qualità del lavoro e dell’assistenza erogata.
Nonostante il costrutto del burnout sia stato ampiamente discusso in ambito psichiatrico e psicologico clinico, persiste una chiara sottostima della sua rilevanza nei programmi di prevenzione, formazione e valutazione del personale, in particolare nei contesti sanitari e educativi. In tali ambienti, le competenze interpersonali sono spesso trascurate a favore delle abilità tecniche ed economiche. Questo approccio favorisce una tendenza alla negazione dell’individualità e promuove il conformismo, rendendo gli operatori più vulnerabili.
La mission di ogni organizzazione dovrebbe includere una valutazione sistematica dell’ambiente di lavoro e delle sue risorse umane, attribuendo agli indicatori di stress, burnout e alessitimia la medesima importanza conferita alla produttività. Sebbene il D.Lgs 81/2008 imponga esplicitamente la valutazione dello stress lavoro-correlato e l’adozione di provvedimenti antistress, solo recentemente il fenomeno del burnout ha guadagnato la dovuta attenzione da parte della Comunità Scientifica e delle Istituzioni. Questo rinnovato interesse è motivato non solo dagli ingenti costi personali per gli individui che subiscono il lento declino causato dalla sindrome, ma anche dalle significative ripercussioni sulla collettività, che risente di un’assistenza e di servizi deficitari.
Dottor Muttillo, come si può promuovere l’engagement in sanità?
Negli ultimi anni, il Sistema Sanitario ha dovuto affrontare nuove sfide, legate da un lato all’aumento delle domande di cura e assistenza di condizioni croniche, e dall’altro alla riduzione delle risorse economiche e umane destinate alla sanità. In tempi più recenti, l’emergenza sanitaria dovuta all’enorme impatto che il COVID-19 ha avuto sugli operatori sanitari e sugli utenti ha favorito profondi cambiamenti verso lo sviluppo di una cultura organizzativa proattiva, di nuovi modelli di assistenza sociosanitaria, e di una crescita esponenziale del desiderio di partecipazione degli utenti alla gestione della propria salute.
In questo scenario di trasformazione e mutamento del contesto sanitario diventa urgente trovare nuove strategie che consentano ai servizi sociosanitari di essere sostenibili, efficaci e finalizzati alla promozione della salute delle persone nel loro percorso sanitario.
In quest’ottica, si evidenzia oggi la consapevolezza di ripensare al modus operandi delle aziende sanitarie, finalizzate proprio alla promozione della salute degli operatori, ma soprattutto degli utenti attraverso lo sviluppo del processo di engagement nella relazione di cura.
In particolare, il work engagement (cioè l’impegno e il coinvolgimento attivo del lavoratore) ha rappresentato la modalità predominante per la maggior parte delle équipe sanitarie.
Inoltre, favorire un buon work engagement, ossia un coinvolgimento attivo e sano dell’operatore sanitario nella sua equipe e organizzazione, rende più facile l’individuazione di segni di burnout e quindi di disagio psicologico legati a un lavoro usurante.
Prendersi cura di chi ci cura, in sintesi, è la vera chiave per garantire un sistema sanitario realmente efficace e sostenibile, Dott. Muttillo?
Questa domanda trova un forte supporto nella letteratura scientifica e nelle evidenze empiriche. La salute e il benessere del personale sanitario non sono semplicemente un aspetto etico o morale, ma rappresentano una variabile critica con impatti diretti e misurabili sull’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità dei sistemi sanitari.
Impatto sulla qualità e sicurezza delle cure
Numerosi studi hanno stabilito una correlazione inversa tra il benessere degli operatori sanitari (e l’assenza di burnout) e gli errori medici, le infezioni nosocomiali e gli eventi avversi. Personale esausto, demotivato o depersonalizzato tende a commettere più errori diagnostici e terapeutici, ad avere minori capacità di attenzione e a mostrare una ridotta adesione ai protocolli di sicurezza. Al contrario, operatori che si sentono supportati e valorizzati sono più attenti, empatici e in grado di fornire cure di alta qualità, contribuendo a migliorare gli esiti per i pazienti e la loro sicurezza.
Riduzione dell’assenteismo e del turnover
Il burnout e lo stress lavoro-correlato sono tra le principali cause di assenteismo per malattia e di turnover del personale nel settore sanitario. Un’elevata rotazione del personale comporta costi significativi per i sistemi sanitari, legati al reclutamento, alla formazione e all’integrazione di nuove figure. Inoltre, la perdita di personale esperto e qualificato erode il capitale umano e la memoria organizzativa, compromettendo la continuità e la qualità dell’assistenza. Investire nel benessere dei curanti riduce queste dinamiche negative, garantendo una maggiore stabilità e continuità nel personale.
Miglioramento della produttività ed efficienza organizzativa
Il benessere psicofisico del personale si traduce in una maggiore motivazione, engagement e produttività. Operatori meno stressati sono più resilienti, innovativi e in grado di affrontare le sfide quotidiane con maggiore energia e creatività. Questo si riflette in una migliore performance complessiva dell’organizzazione sanitaria, ottimizzando l’utilizzo delle risorse e riducendo gli sprechi legati a inefficienze e errori.
Sostenibilità finanziaria del sistema
Sebbene gli interventi a supporto del personale richiedano un investimento iniziale, i dati dimostrano che questi si traducono in un risparmio a lungo termine. I costi associati al burnout (assenze, turnover, errori medici, cause legali, calo di produttività) sono notevoli. Prendersi cura di chi ci cura è, quindi, una strategia economicamente vantaggiosa che contribuisce alla sostenibilità finanziaria del sistema sanitario, riducendo le spese indirette e migliorando il ritorno sugli investimenti in capitale umano.
Impatto sulla sanità pubblica e resilienza del Sistema
In un contesto di crescenti sfide, demografiche ed epidemiologiche, avere un personale sanitario motivato e resiliente è fondamentale per la capacità di risposta e l’adattamento del sistema sanitario, salvaguardando la salute pubblica nel suo complesso.
In conclusione, l’evidenza scientifica supporta in modo inequivocabile l’argomentazione che prendersi cura di chi ci cura è una necessità strategica. È la vera chiave di volta per costruire e mantenere un sistema sanitario che sia non solo efficace nella sua missione di cura, ma anche sostenibile nel lungo periodo, capace di adattarsi alle sfide e di garantire benessere sia a chi eroga l’assistenza sia a chi la riceve.